Cos'è questa storia del fact-checking su Facebook?
Cosa ci ha raccontato Giovanni Zagni, cosa ha scritto Walter Quattrociocchi e come Jon Slow mi ha aiutato a conciliare le due posizioni
Appena Zuckerberg ha fatto la sua apparizione social con catenazze dorate in questa sua nuova versione pubblica che poi lo ha portato anche a finire ospite da Joe Rogan e ha fatto diventare il fact-checking famoso per due giorni, ho pensato a due persone.
Una di queste persone è Giovanni Zagni, direttore di Pagella Politica e Facta. L’altra è Walter Quattrociocchi, professore alla Sapienza di Roma e a capo del Center of Data Science and Complexity for Society (CDCS).
Conosco entrambi, apprezzo entrambi, entrambi sono stati ospiti di eventi di Slow News e li reinviteremo molto volentieri. So che hanno posizioni molto diverse rispetto al fact-checking e penso sia utile vederle rappresentate per poi fare insieme qualche considerazione.
Macchine da intrattenimento
Partiamo da Quattrociocchi: dopo l’annuncio di Zuckerberg della chiusura del progetto di fact-checking sulle proprietà di Meta negli Stati Uniti ha scritto un articolo per il Corriere della Sera. Il titolo è di quelli che triggerano i giornalisti: “Il fact-checking è stato un fallimento ma nessuno vuole dirlo”. È un titolo riuscito.
Quattrociocchi ha anche lungamente spiegato le sue posizioni e i suoi studi nell’ecosistema social.
Su LinkedIn ha scritto un post – e svariati commenti che consiglio di recuperare seguendo la conversazione – in cui riassume le posizioni che derivano da anni di studi di dati e di dinamiche dell’ecosistema social. Ho aggiunto qualche link e qualche grassetto.
”Negli ultimi giorni, l’annuncio di Meta di abbandonare il fact-checking per un sistema basato sulle “Community Notes” ha fatto discutere. È una mossa che molti vedono come rivoluzionaria, ma che in realtà nasconde un’ammissione implicita: il fact-checking non funziona. E non funziona da anni.
La comunità scientifica lo aveva già dimostrato. Già nel nostro lavoro Debunking in a World of Tribes [2017], avevamo mostrato che il fact-checking, lungi dall'essere una soluzione, spesso peggiora le cose, rafforzando la polarizzazione e consolidando le echo chamber. Eppure, nonostante queste evidenze, milioni di dollari sono stati spesi in soluzioni che chiunque con un minimo di onestà intellettuale avrebbe riconosciuto come fallimentari. Duncan Watts, in un recente articolo pubblicato su Nature [Misunderstanding the harms of online misinformation, 2024], ha sottolineato come il discorso di intellettuali e giornalisti sulla disinformazione sia spesso scollegato dalla realtà. Si parla di fake news come se fossero il problema principale, ignorando completamente che è il modello di business delle piattaforme a creare le condizioni per cui la disinformazione prospera. La verità, nella sua accezione più ampia, è spesso ambigua, contestuale e soggetta a interpretazioni. Il fact-checking, così come è stato concepito, non può che fallire nel risolvere il problema della disinformazione, poiché si limita a contrapporre “etichette” alla viralità emotiva dei contenuti.
Le piattaforme social non sono progettate per essere strumenti di informazione, ma macchine per l'intrattenimento. Premiano ciò che cattura l’attenzione, che emoziona, che divide, perché è questo che genera engagement. Non è un sistema costruito per garantire la qualità dell’informazione, ma per massimizzare il tempo che le persone trascorrono online.
Per anni, alcuni hanno cercato, ignorando le evidenze scientifiche, di mantenere il mondo dell’informazione come era prima dell’avvento dei social media. Il punto, però, è che non è mai stato possibile arginare questa trasformazione. Imporre dall’alto un modello di controllo non ha mai funzionato. Ne sappiamo qualcosa fin dai tempi del Sant’Uffizio, che con i suoi roghi di libri non ha certo impedito alla scienza di progredire.
L’unico antidoto possibile, e lo abbiamo visto chiaramente, è rendere gli utenti consapevoli di come interagiamo sui social. Non c’è altra strada. Una riflessione collettiva sul nostro comportamento online è la chiave per affrontare il problema alla radice”.
Cosa fanno i fact-checker su Meta?
Zagni, invece, quando ho iniziato a lavorare a questo numero della newsletter, non si era ancora espresso pubblicamente. Così gli ho mandato alcune domande via mail e lui ha risposto. Mi interessava soprattutto fare ordine rispetto al significato pratico delle decisioni di Zuckerberg – al di là di quelle politiche e di business, insomma – e cercare di capire bene che lavoro viene fatto in questo momento e che cosa non verrà più fatto.
Puoi spiegarci cosa significa esattamente l'annuncio di Meta rispetto al fact-checking?
Dal 2016 Meta aveva in corso un programma di partnership con diverse decine di organizzazioni di fact-checking in tutto il mondo. Il programma, chiamato Third Party Fact-checking Program (3PFC) era partito inizialmente negli Stati Uniti, in conseguenza delle critiche per la diffusione di notizie false sulla piattaforma e delle accuse che queste ultime avessero influenzato in modo decisivo l’esito delle elezioni presidenziali del 2016. Il 3PFC si era poi espanso a molti Paesi nel mondo, fino a coinvolgere un centinaio di progetti che lavorano in 60 lingue diverse.
Abbiamo descritto più nel dettaglio il 3PFC in questo articolo su Facta. Il 7 gennaio 2025 Mark Zuckerberg in persona, insieme al nuovo responsabile degli affari globali dell’azienda Joel Kaplan, ha annunciato la fine di questo sistema «a partire» dagli Stati Uniti, per muoversi verso un sistema di “community notes” come quello di X [ex Twitter], citato esplicitamente come modello. Le organizzazioni di fact-checking statunitensi parte del programma smetteranno di lavorare su Meta nell’arco di un paio di mesi. Al momento non si sanno con certezza le conseguenze per il 3PFC fuori dagli USA, anche se è chiaro che l’appoggio del capo di Meta non c’è più.
Da quanto tempo lavorate per Meta e con che condizioni (quelle che puoi dirci) e con che libertà d'azione?
Abbiamo cominciato a lavorare per Meta tra i primi in Europa e fuori dagli Stati Uniti, a gennaio 2018. Per un paio d’anni come Pagella Politica, poi da inizio 2020 esclusivamente tramite il nostro progetto “gemello” Facta. Per molto tempo siamo stati gli unici partner in Italia, più tardi (a ottobre 2021) si è aggiunto anche Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana.
Tuttora facciamo parte della partnership: in massima libertà, devo dire, perché non abbiamo mai ricevuto alcuna interferenza nelle nostre scelte su cosa e come verificare. Ovviamente rispettando le linee guida che sono fornite da Meta e che sono pubblicamente disponibili ad esempio qui.
Vorrei che non ci fossero fraintendimenti su quello che facciamo, quindi sottolineo subito un paio di cose:
i contenuti che verifichiamo non vengono rimossi (ma ci vengono applicate delle etichette con link agli articoli di fact-checking)
non verifichiamo contenuti postati da partiti e da esponenti politici, l’attività di fact-checking politico che portiamo avanti con Pagella Politica è del tutto separata e non ha alcun impatto sulla partnership con Meta.
Forse molte persone non sanno esattamente come funziona il fact checking sulle piattaforme di Meta. Puoi spiegarcelo?
Vi rimando al pezzo più esteso che citavo sopra, ma in breve funziona così: i fact-checker hanno accesso a una lista di segnalazioni degli utenti che hanno indicato alcuni contenuti come possibili notizie false e possono aggiungere a loro volta contenuti alla lista, ad esempio perché abbiamo ricevuto una segnalazione tramite il nostro numero WhatsApp o un messaggio diretto sui social. Se un contenuto è falso – ad esempio una foto presentata con il contesto sbagliato, una notizia inventata e così via – scriviamo un articolo con la verifica, fornito di tutte le fonti, e lo “restituiamo” a Meta.
La lista completa degli articoli che facciamo per Meta è disponibile qui sul nostro sito, così ciascuno si può fare un’idea del tipo di cose che verifichiamo: si tratta per lo più di invenzioni, assurdità varie, bufale, a volte potenzialmente dannose, certo non di controverse opinioni politiche.
A sua volta, il social network di Meta – il sistema è in sostanza lo stesso per Instagram, Facebook e Threads – associa il contenuto all’articolo con un sistema di etichette e ne riduce la diffusione. Se gli utenti vogliono, possono comunque vedere e condividere lo stesso quel contenuto.
Come si accorgono gli utenti che c'è stato un lavoro da parte di un fact checker?
Compare un’etichetta o una copertura che dice qualcosa del tipo “Questo contenuto è stato valutato come falso da fact-checker indipendenti”.
Il lavoro dei fact checker c'entra qualcosa con gli "shadowban" di meta?
Non che io sappia. Aggiungo che il programma di collaborazione con i fact-checker non ha a che fare con le politiche di moderazione in generale, ad esempio per violenza, bullismo e così via, che sono gestite separatamente e in modi che non conosco nel dettaglio.
Hai idea di cosa succederà in Europa?
No, né noi né i nostri altri colleghi europei abbiamo certezze, anche se per il momento le modifiche sono valide solo negli Stati Uniti.
Opinioni personali sulle "Community Notes"?
Ho accesso al sistema delle Community Notes su X e lo trovo, almeno su quella piattaforma, un sistema rudimentale e con un grande rumore di fondo. Gli utenti scrivono una quantità spropositata di note non necessarie e che non verranno mai visualizzate. Spesso si finisce in discussioni che sono vicoli ciechi e ci sono moltissime duplicazioni e note non necessarie. Ho smesso molto presto di contribuire: perché un utente disinteressato e in buona fede dovrebbe spendere ore a leggere commenti inutili? Sospetto che quelli che vi si impegneranno saranno gli utenti più motivati da altre convinzioni (ad esempio politiche) piuttosto che dalla volontà di creare un dibattito spassionato. E che presto bisognerà introdurre una gerarchia tra utenti moderatori, alla Wikipedia, selezionando quelli che sono in grado di selezionare le fonti corrette, scrivere in modo chiaro e completo le proprie motivazioni per una verifica... A quel punto, rientrano dalla finestra i fact-checker che erano stati fatti uscire dalla porta.
Vedi un ruolo futuro per il fact-checking sui social?
Il fact-checking è un modo di fornire agli utenti del contesto e, se possibile, delle informazioni chiare e verificate a corredo di materiali già disponibili online. Certo può essere fatto bene o male, ma quando è fatto bene è un utile servizio. E in quanto tale è qui per restare, in tutti i canali di comunicazione, inclusi i social network.
La consapevolezza è la chiave
Ora, credo, sappiamo qualcosa in più.
Sappiamo che tipo di lavoro fanno i fact-checker indipendenti su Meta. Sappiamo anche che le piattaforme social non sono progettate per essere strumenti di informazione, ma macchine per l'intrattenimento.
Provare a conciliare le due posizioni di Quattrociocchi e Zagni non è un esercizio democristiano ma un lavoro necessario.
Tanto per cominciare hanno un fondamento comune: la necessità di creare consapevolezza nelle persone.
Creare consapevolezza signific dare contesto e offrire informazioni corrette, verificate e verificabili e anche rendere le persone in grado di comprendere il funzionamento dei social e, più in generale, delle strutture sociali che frequentano.
Visto che lo stesso funzionamento dei social, che premiano i contenuti polarizzanti e divisivi – qui un racconto leggero di quel che mi è successo quando è partita la rage machine su Facebook – “crea le condizioni per cui la disinformazione prospera”, è per forza di cose quello il primo tassello da sistemare.
Breve excursus “storico”
Il problema è che per anni si è pensato che i giornali potessero trovare una loro dimensione sui social. Quando dirigevo Blogo.it (2013-2016) mi sembrava che fosse semplicemente impossibile, perché il tipo di contenuti che dovevi produrre ad ogni costo per soddisfare il funzionamento della piattaforma richiedeva di scendere a compromessi con gli algoritmi di distribuzione dei contenuti stessi. Compromessi che erano semplicemente inaccettabili per un giornalista. Mentre, come redazione, cercavamo di costruire una crescita organica, lenta ma solida, basata essenzialmente sui motori di ricerca, venivamo costretti da scelte miopi a perseguire il traffico ad ogni costo (e così apparivano sulle nostre pagine social robe non scritte da giornalisti di puro intrattenimenti, quando non proprio di spazzatura tipo “La strega serba che ha previsto l’elezione di Trump”). E non eravamo mica i soli a inseguire il mito della quantità e velocità: ricordo che un giorno, insegnando a un corso per giornalisti, un collega mi disse che il suo compito era quello di postare un contenuto ogni 15 minuti sul Milan. Non è un caso che mi sia messo a fare un progetto che si chiama Slow News.
Poi, probabilmente, qualcuno ce l’ha fatta a domare questa impossibilità (dovremmo metterci ad analizzare bene cosa voglia dire “avercela fatta”, ma non è questa la sede) e ci sono eccezioni che dovremmo considerare: nessuno si offenda. Solo che la produzione di giornalismo di qualità richiede tempo, ricerca, studio: tutto il contrario della velocità, dell’emotività, della polarizzazione, della necessità di mantenere il ritmo, riempire gli spazi, colmare i vuoti, seguire i palinsesti, tenere alta l’attenzione.
“I protagonisti del giornalismo online in Italia stanno facendo di tutto per impiccarsi all’ultimo click”, scrivevo nel 2015 ricevendo come gentile omaggio una vignetta a tema da parte di Mauro Biani.
I giornali si sono legati mani e piedi al traffico – sempre meno – che proveniva dai motori di ricerca e poi dai social, appunto, senza capirne la natura da walled garden. Fatta la scelta di stare sulle piattaforme social hanno dovuto introiettare le logiche e hanno fatto proprio persino il modello di business dell’intrattenimento: i clic che generano ricavi con la pubblicità sono un modello di business perfetto per l’intrattenimento. E una trappola mortale per il giornalismo.
“Facebook ha una sua convenienza propria che sta sviluppando senza mezzi termini”, scrivevo ancora nel 2016. Questa convenienza era ed è “mantenere l’utente al proprio interno”. Ma a dirlo sembrava di essere degli eretici allora e ora ci si sente cassandre o forse mitomani.
E allora?
E allora trovare il modo di fare una sintesi creativa di quello che hanno raccontato Zagni e Quattrociocchi, per me, è semplicemente necessario, perché credo che sia da lì che si possa partire per far germogliare qualcosa di diverso da quel che si è fatto fin qui.
In fondo il metodo della verifica – non certo l’emotività – è l’unica cosa che distingue il giornalismo da qualsiasi altro tipo di produzione di contenuti. È per quello che quando una giornalista legge che il fact-checking è un fallimento salta sulla sedia. Perché in qualche modo il fact-checking è parte integrante del lavoro giornalistico (o almeno: dovrebbe esserlo). Solo che… come fai a fare fact-checking dell’intrattenimento? Quel che fallisce è il tentativo di etichettare, di arginare, di riprodurre la scarsità dell’informazione, di contenere. Ma il giornalismo non deve contenere. Deve dare strumenti.
Non c’è mai stato così tanto bisogno come oggi di grande giornalismo: il giornalismo che rende le persone consapevoli, che si fonda sui fatti, sui dati, sulla verifica, che si corregge, che fa del metodo della verifica – e dunque del metodo scientifico – la propria essenza. Difficile, però, che trovi spazio nei posti fondati da gente che, da un giorno all’altro, ti tira fuori le catenazze d’oro e che voleva solo – da sempre – fare più soldi grazie all’emotività.
A proposito di soldi: The Slow Journalist si sostiene anche grazie alle abbonate e agli abbonati a Slow News (si fa qui) e con i corsi che proponiamo. In questo momento va alla grande il corso AI@Work: parte il 14 gennaio, si rivede quando vuoi, esce con calma, una volta a settimana e, soprattutto, ha il prezzo bloccato fino al 31 gennaio.
Buon fine settimana,
Alberto & Jon Slow






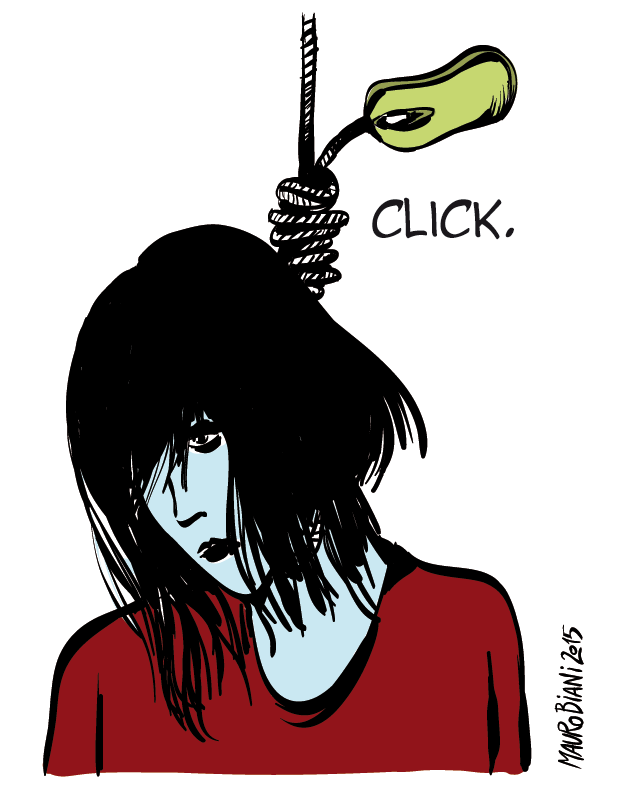
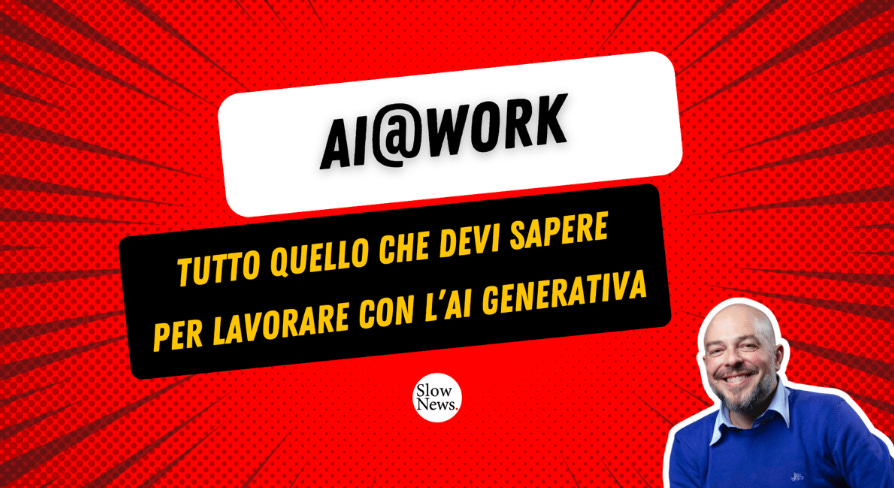
Grazie Alberto questo pezzo è veramente illuminante. Io pendo d di più come giornalista verso il “mito” del fact checking, ma in effetti il pezzo di Quattrociocchi punta il dito su una cosa talmente gigantesca che tendiamo a dimenticarla. La storia del giornalismo sui social è piena di accidenti ma è probabilmente una storia… che non sarebbe dovuta nemmeno iniziare 😁 Battaglia persa in partenza? Vedremo. Intanto queste riflessioni arricchiscono.
Grazie Alberto, credo che la tua sia una sintesi perfetta ed equilibrata che si giova adeguatamente delle due gambe che hai citato - lavoro sul campo e ricerca scientifica -, appartenenti a due validi professionisti nel loro settore.
Ancora una volta emerge il compito improcrastinabile individuale (che poi diventa collettivo) di metterci del proprio e non demandare al "rumore" della massa la conquista della propria libertà. "Libertà è partecipazione" cantava qualcuno; studiare, rallentare, far sedimentare ed amalgamare è la chiave di questa libertà.